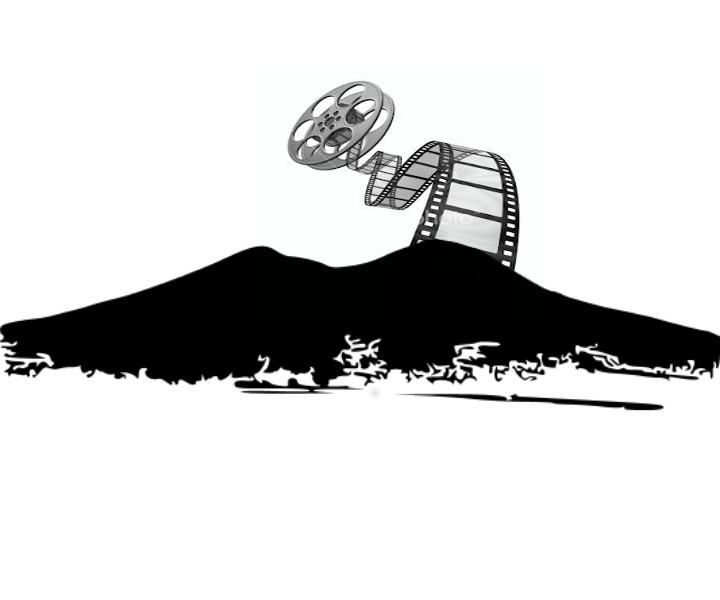“I cinghiali di Portici” di Diego Olivares – storie di rugby e riscatto sociale

Nello scenario variegato del cinema italiano esistono realtà che nonostante il loro valore hanno difficoltà incredibili nel venir fuori, nel farsi produrre, nel farsi distribuire. Può capitare che dopo aver girato un film, averlo presentato a un festival ricevendo una menzione per la sceneggiatura (Torino Film Festival 2003) e dopo aver vinto nel 2004 il Premio Sergio Leone, che dovrebbe assicurare l’uscita in sala grazie all’Istituto Luce, si debba prendere la pellicola e riporla in archivio per mancanza di distribuzione: questa è la storia dell’esordio del regista Diego Olivares, che nell’estate del 2002 gira a basso costo I cinghiali di Portici con l’intento di farlo uscire di lì a poco nelle sale senza però riuscirci nemmeno quando un riconoscimento dovrebbe facilitargli l’operazione…peccato che l’Istituto Luce non fosse a conoscenza di questo impegno che avrebbe dovuto mantenere.
Col passare del tempo regista e attori avevano ormai perso le speranze di poter vedere il loro film nei cinema, e invece nel 2006, a distanza di circa 4 anni, questa sorta di parabola sulla disillusione è riuscita ad arrivare in sala. I cinghiali di Portici racconta di come un gruppo di ragazzi, all’interno di una comunità di recupero per tossicodipendenti e giovani disagiati, sia spinto da un operatore sociale a cimentarsi con il rugby, tra struzzi e cinghiali che vengono allevati nel centro, rivelando insospettabili doti agonistiche e cominciando un percorso para professionistico che potrebbe cambiare i destini di alcuni di loro.


La bravura di Olivares sta nel raccontare questa storia senza compiacimenti per lo spettatore, senza quelle facili astuzie ben conosciute dalla contemporanea cinematografia nostrana sempre pronta a venire incontro alle esigenze e alle volontà del pubblico; I cinghiali di Portici è crudo per le vite dei ragazzi protagonisti della vicenda ma mai torbido, l’occhio registico è interessato alle ferite dell’anima non a quelle del corpo ed infatti una delle scelte più indovinate è quella di far sentire le voci dei ragazzi come sottofondo a tutto il film, quasi come se fossero le loro anime a parlare, le loro anime malate, alcune in via di guarigione altre disilluse dal possibile raggiungimento di questa.
La pellicola è stata girata a Portici, periferia di Napoli, in un edificio storico come la Casa Materna che, a due passi dal Museo di Pietrarsa sempre presente sullo sfondo, affaccia sul mare ed è separato da esso dai quanto mai simbolici binari di una ferrovia (la Napoli – Portici, la prima ferrovia d’Italia), al cui rumore ci si abitua ma a cui non si riesce a non pensare come possibile mezzo di fuga da quel luogo in cui si è costretti a stare per ripulirsi; molte comparse e alcuni dei co-protagonisti sono ragazzi che realmente abitavano in una comunità, Il Pioppo, alle pendici del Vesuvio.

A fare da collante ai tanti giovani esordienti (Antonia Truppo, Carmine Recano, Vincenzo Pirozzi, Carlo Caracciolo), oltre alla già esperta Alessandra Borgia, c’è il bravissimo Ninni Bruschetta, (conosciuto in Libera e apprezzato in I cento passi e La vita che vorrei e divenuto popolare grazie al ruolo del mitico direttore della fotografia nella serie tv Boris), scelto non a caso per i suoi trascorsi in ambito rugbistico; nella parte di un operatore della comunità di recupero sempre alle prese con i problemi di spese e di burocrazia, scopre un giorno che attraverso il rugby può aiutare i suoi ragazzi, ad educarli al rispetto verso se stessi e verso gli altri, può aiutarli a stare bene anche in quella condizione di costrizione che li rende e li fa sentire ancora più diversi di quanto in realtà non siano.
La bellezza di questa pellicola è nella genuinità dei personaggi e soprattutto nel finale che spiazza perché lontano anni luce da quei film di genere (in questo caso sportivo) che rendono tutto facile e che chiudono il cerchio in maniera perfetta, non avvicinandosi quasi mai alla realtà; I cinghiali di Portici, nel solco del cinema neorealista, evita di dare un finale qualsiasi che banalizzerebbe la storia e rende lo spettatore giudice supremo di una vicenda che, come troppe volte al giorno d’oggi, non lascia tante vie d’uscita.